Gli insegnanti aprono le porte, ma tu devi entrare da solo.
Proverbio cinese
Nel 2025, la retribuzione dei professori universitari italiani continua a essere un tema di grande interesse pubblico — non solo per chi lavora nel mondo accademico, ma anche per chi si interroga sul valore attribuito alla conoscenza e alla ricerca nel nostro Paese. Diventare docente universitario in Italia è un percorso lungo e competitivo, scandito da concorsi, pubblicazioni scientifiche e anni di precariato come ricercatore. Tuttavia, nonostante la complessità del percorso e l’elevato livello di qualificazione richiesto, gli stipendi dei professori italiani restano mediamente inferiori alla media europea, soprattutto rispetto a paesi come Germania, Francia o Regno Unito.
Il sistema retributivo si basa su fasce e scatti di anzianità: si parte dai ricercatori a tempo determinato, spesso con contratti triennali, per poi passare ai professori associati (II fascia) e infine ai professori ordinari (I fascia). Gli stipendi aumentano con gli anni di servizio e con i risultati accademici, ma le differenze restano significative. Un docente ordinario con lunga carriera può superare i 120.000 euro lordi annui, mentre un giovane ricercatore raramente oltrepassa i 40.000.
| RUOLO ACCADEMICO | STIPENDIO NETTO MENSILE |
|---|---|
| Ricercatore a tempo determinato (RTD-A) | €1.600 – €1.900 |
| Ricercatore a tempo determinato (RTD-B) | Ricercatore a tempo determinato (RTD-B) |
| Professore associato (II fascia) | €2.400 – €3.300 |
| Professore ordinario (I fascia) | €3.800 – €5.500 |
La situazione varia anche a seconda del territorio: nelle grandi città universitarie del Nord, il potere d’acquisto è spesso più basso a causa del costo della vita, mentre nei centri del Sud lo stipendio mantiene un peso maggiore sul reddito reale, pur con minori opportunità di ricerca e fondi. In questo quadro complesso, conoscere le fasce retributive aggiornate al 2025 aiuta a comprendere meglio non solo quanto guadagnano i docenti, ma anche quale valore economico e simbolico attribuiamo oggi all’insegnamento universitario.
In questo articolo mostreremo una breve panoramica di tutte le caratteristiche di un docente universitario, delle mansioni da svolgere e dell'aspetto retributivo.

Ruoli e carriere: capire le differenze tra RTD-A, RTD-B, associato e ordinario
Il percorso accademico in Italia è una vera e propria scalata a tappe, regolata da concorsi pubblici, abilitazioni nazionali e una lunga esperienza nella ricerca e nella didattica. Ogni ruolo — dal ricercatore al professore ordinario — rappresenta un gradino con precise differenze di status, stabilità e autonomia.

Diventare ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A) costituisce il primo passo della carriera universitaria dopo il dottorato. Si tratta di un ruolo legato a un contratto a termine di tre anni, non rinnovabile, che offre la possibilità di svolgere attività di ricerca e un numero limitato di ore di didattica.
L’RTD-A non offre garanzie circa la prosecuzione nel mondo accademico: alla scadenza del contratto è possibile partecipare a nuovi bandi, ma vi è garanzia di una stabilizzazione del contratta.
Diverso è il ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTD-B), introdotto con la riforma Gelmini e pensato come figura di transizione verso la stabilità. Anche in questo caso il contratto dura tre anni, ma prevede la chiamata diretta come professore associato nel caso in cui il candidato venga valutato positivamente e se l’ateneo dispone dei fondi necessari per offrire un contratto. L’RTD-B partecipa in modo più esteso alla vita del dipartimento: tiene corsi, segue studenti e dottorandi, coordina progetti di ricerca e pubblica in riviste scientifiche di rilievo. È la figura-ponte tra il precariato e una carriera stabile.
Il professore associato (II fascia) rappresenta il primo vero ruolo stabile della docenza universitaria.
È assunto a tempo indeterminato, con piene responsabilità didattiche e scientifiche: può dirigere tesi di laurea e dottorato, ottenere finanziamenti di ricerca e ricoprire incarichi istituzionali nei consigli di dipartimento.
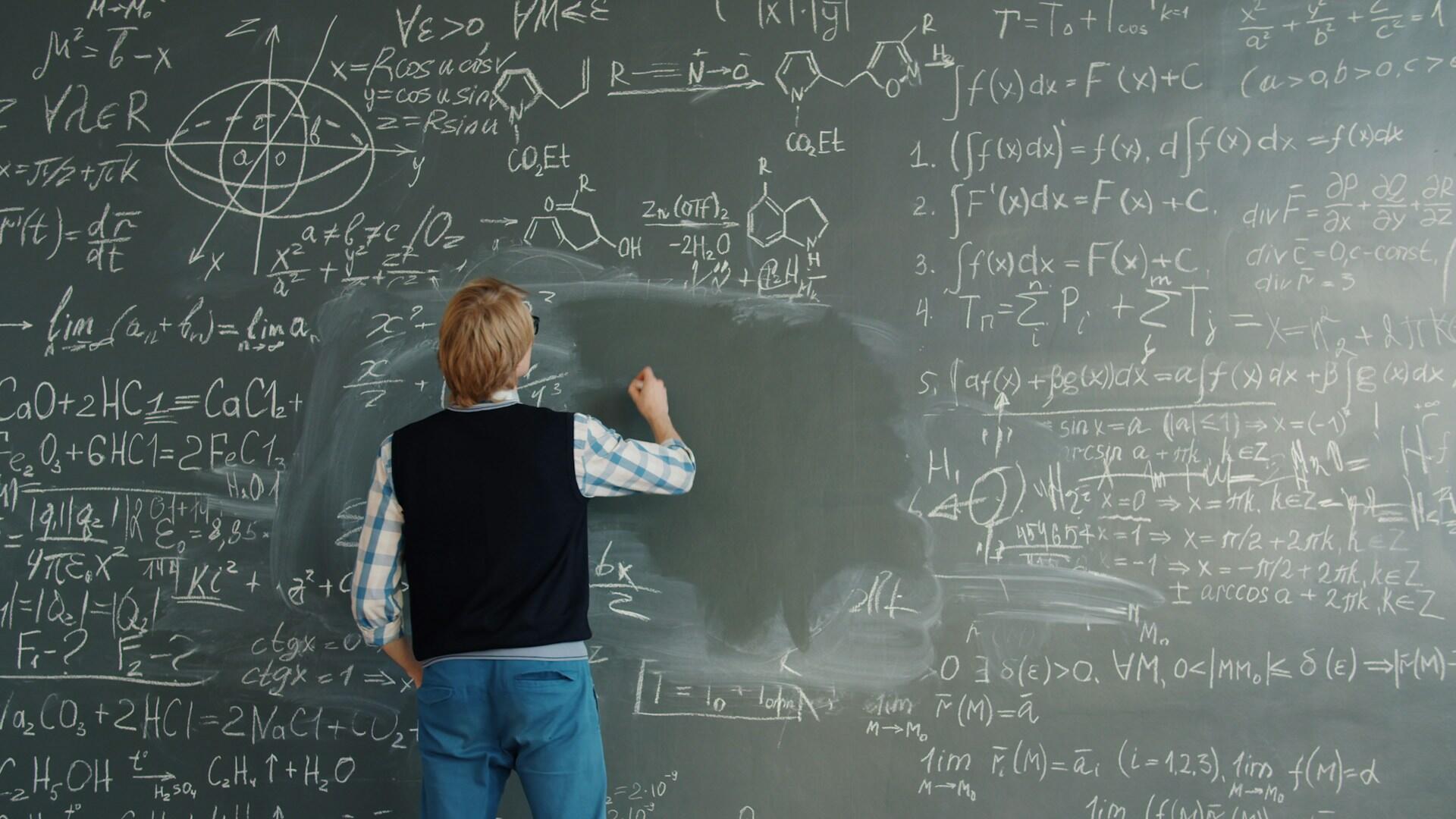
L’accesso a questo ruolo richiede l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), un titolo che certifica il livello di produzione scientifica necessario per entrare nella fascia docente. Il professore associato è quindi una figura centrale nella vita accademica, con autonomia e continuità di carriera.
Al vertice si colloca il professore ordinario (I fascia), il grado più alto dell’università italiana. È il docente che rappresenta l’eccellenza accademica e scientifica del proprio settore, spesso a capo di dipartimenti, comitati scientifici o centri di ricerca.

L’ordinario non solo insegna, ma definisce la strategia scientifica e formativa dell’ateneo, coordina progetti internazionali, presiede commissioni e partecipa alle scelte di indirizzo accademico.
Anche per questo ruolo è richiesta l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ma con criteri più selettivi rispetto alla II fascia.
Il passaggio da un gradino all’altro resta lungo e competitivo: in media, possono trascorrere anche 10–15 anni dal dottorato alla stabilizzazione come professore associato. Una dinamica che spiega perché il tema degli stipendi e della progressione di carriera da docente universitario resti oggi al centro del dibattito sul futuro dell’università italiana.
Ricercatori universitari RTD-A e RTD-B: stipendi, mansioni e prospettive nel 2025
Nel panorama accademico italiano, i ricercatori a tempo determinato rappresentano la base della piramide universitaria: figure altamente qualificate, spesso con anni di formazione post-dottorale alle spalle.

Le sigle RTD-A e RTD-B indicano due ruoli distinti, regolati da contratti a tempo determinato, ma con differenze sostanziali in termini di stabilità, salario e prospettive future.
Ricercatore RTD-A
Il ricercatore RTD-A (Tipo A) è inquadrato come figura junior della ricerca universitaria:
- il suo contratto dura tre anni non rinnovabili, con un impegno annuale di 350 ore complessive, di cui circa 60 di didattica (seminari, esercitazioni o co-docenze);
- la parte principale del suo lavoro riguarda la ricerca scientifica, la stesura di articoli, la partecipazione a progetti europei e il supporto ai corsi di laurea.
Tuttavia, l’RTD-A vive una condizione di forte precarietà: allo scadere del contratto, non ha alcuna garanzia di rinnovo o passaggio automatico a posizioni superiori.

Sul piano economico, nel 2025 il ricercatore RTD-A percepisce uno stipendio lordo annuo di circa 38.000–41.000 euro, che corrisponde a un netto mensile medio di 1.600–1.900 euro su tredici mensilità. L’ammontare può variare leggermente a seconda dell’ateneo e dell’anzianità pregressa.
Considerato il livello di qualificazione richiesto (dottorato di ricerca, pubblicazioni, esperienze internazionali), questo reddito è spesso percepito come sotto la media europea per ruoli equivalenti.
Ricercatore RTD-B
Il ricercatore RTD-B (Tipo B) rappresenta invece una figura senior, pensata come ponte verso una carriera accademica stabile:
- Anche in questo caso il contratto è triennale, ma prevede, in caso di valutazione positiva e disponibilità di bilancio dell’ateneo, la chiamata diretta come professore associato;
- l’RTD-B svolge un'attività didattica più estesa (fino a 90 ore l’anno), coordina gli studenti e i dottorandi, partecipa ai bandi e può ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dei gruppi di ricerca.
Dal punto di vista economico, il ricercatore RTD-B guadagna circa 43.000–47.000 euro lordi annui, pari a un netto mensile stimato tra 1.900 e 2.200 euro.
Alcuni atenei più grandi, soprattutto del Nord Italia, possono prevedere piccoli incentivi o fondi di ricerca aggiuntivi, ma la differenza resta marginale.
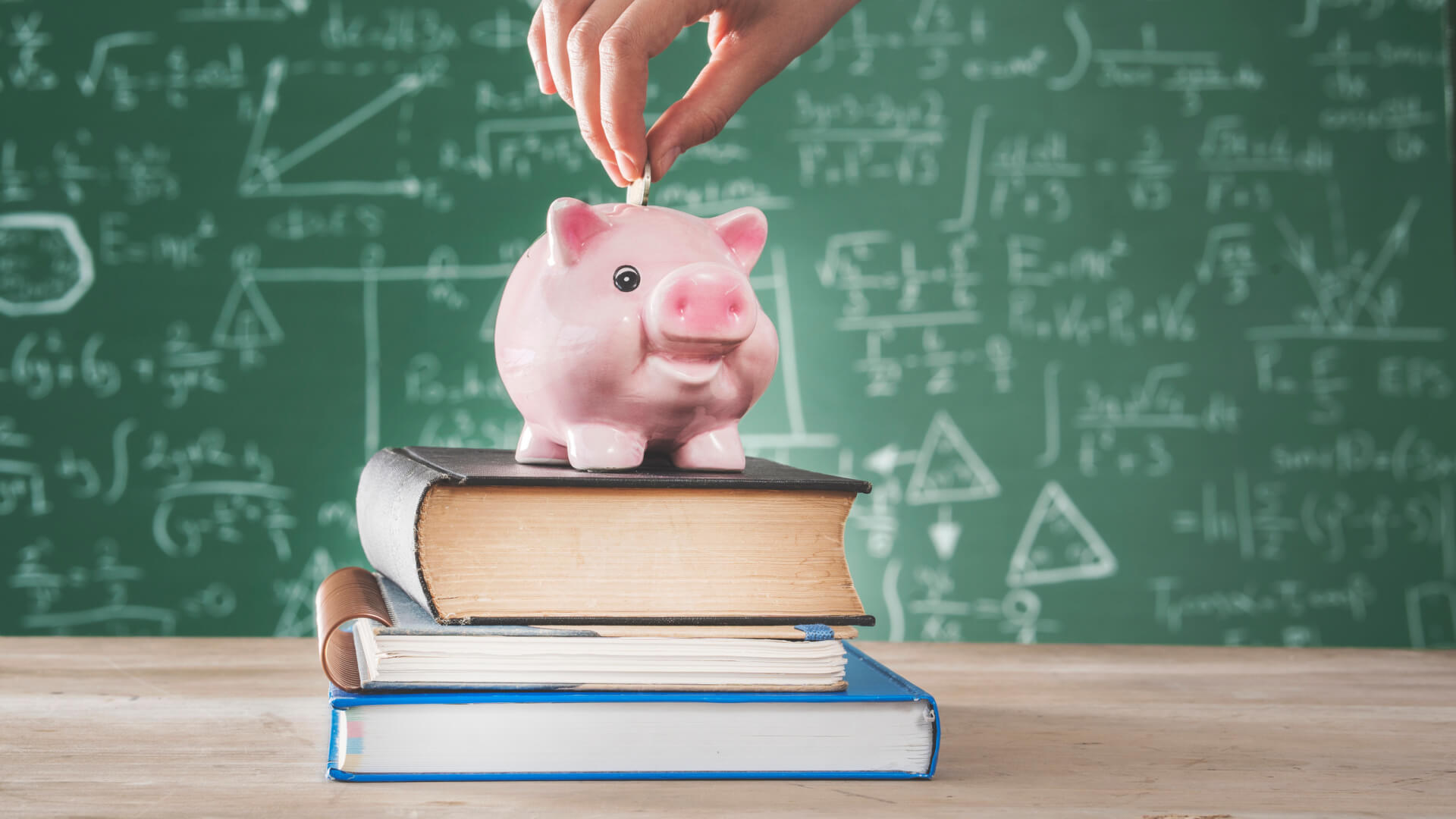
Rispetto all’RTD-A, il miglioramento salariale è modesto, ma il vantaggio reale è la prospettiva di stabilizzazione: il contratto RTD-B è oggi la via principale per accedere al ruolo di professore associato (II fascia).
Tuttavia, anche questa transizione non è automatica. Molti atenei, a causa della scarsità di fondi e del blocco del turnover, non riescono a garantire l’assunzione degli RTD-B al termine del triennio, costringendo molti ricercatori a cercare nuove opportunità o a spostarsi all’estero. Nonostante le riforme più recenti abbiano cercato di rendere il sistema più meritocratico e lineare, la carriera accademica italiana rimane ancora una corsa a ostacoli, dove l’entusiasmo per la ricerca deve spesso convivere con l’incertezza economica e contrattuale.
Insomma, non cifre da capogiro: se non sei mosso da vera passione per la ricerca, ti conviene forse fare altri lavori anche distanti da questo che possono andare a integrare le tue entrate come diventare insegnante, dare lezioni all'aperto oscoprire come diventare personal trainer!
La Carta del Docente è un bonus annuale (tradizionalmente € 500) per la formazione, riconosciuto ai docenti delle scuole statali, non ai docenti universitari. Tale bonus è istituito dalla Legge 107/2015 per il personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche. I docenti universitari non rientrano nella platea dei beneficiari, perché non dipendenti del sistema scolastico statale e non soggetti alle stesse normative di aggiornamento previste per gli insegnanti delle scuole. Con il Decreto Scuola / Legge 45/2025 è stata prevista un’estensione della Carta anche ai docenti con contratti a tempo determinato nelle scuole, ma tale norma non interessa il personale universitario, che resta escluso dalla normativa scolastica
Professori associati e ordinari: didattica, ricerca e responsabilità accademiche
Salendo nella gerarchia universitaria, le figure del professore associato e del professore ordinario rappresentano il cuore della struttura accademica italiana. Sono i ruoli che garantiscono la continuità dell’insegnamento, la guida della ricerca e la rappresentanza scientifica dell’ateneo nei contesti nazionali e internazionali.
Professore associato
l professore associato (II fascia) è il primo vero ruolo a tempo indeterminato nella carriera universitaria. Per accedervi, è necessaria l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), ottenuta tramite la valutazione dei i titoli scientifici, delle pubblicazioni e dell’attività didattica.

L’associato gode di piena autonomia nella didattica:
- tiene corsi universitari completi
- coordina tesi e dottorati
- partecipa ai consigli di dipartimento
- può dirigere progetti di ricerca.
Tuttavia, deve spesso conciliare l’insegnamento con la produzione scientifica, requisito fondamentale per la progressione verso la prima fascia.
Sul piano economico, nel 2025 lo stipendio lordo annuo di un professore associato varia in media tra 56.000 e 80.000 euro, a seconda degli scatti di anzianità e degli incentivi legati a incarichi o progetti esterni. Il netto mensile oscilla dunque tra 2.400 e 3.300 euro, con valori leggermente più alti negli atenei del Nord.
Professore ordinario
Al vertice della carriera universitaria si trova il professore ordinario (I fascia), figura di riferimento scientifico e istituzionale.

Oltre a insegnare e dirigere gruppi di ricerca, l’ordinario assume spesso ruoli gestionali e rappresentativi: presiede consigli di corso di laurea, gestisce i comitati di dottorato, presiede i centri di ricerca, partecipa ai processi di valutazione e accreditamento.
È, in sostanza, la colonna portante dell’università italiana, responsabile del coordinamento tra didattica e ricerca, nonché della formazione delle nuove generazioni di studiosi.
Gli stipendi di un professore ordinario nel 2025 partono da circa 80.000 euro lordi annui, ma con l’anzianità e gli incarichi aggiuntivi (direzioni, commissioni, progetti europei) possono superare i 120.000 euro. Il netto mensile medio si colloca pertanto tra 3.800 e 5.500 euro, con punte oltre i 6.000 per i docenti più anziani o con ruoli di rilievo amministrativo.
Oltre al salario base, gli ordinari possono ricevere compensi extra per la partecipazione a bandi competitivi, attività di consulenza, pubblicazioni e progetti finanziati.
Nel sistema universitario italiano, la progressione economica dei docenti segue un meccanismo di scatti automatici e incrementi per anzianità di servizio, che variano in base al ruolo accademico.
Per i ricercatori a tempo determinato (RTD-A e RTD-B), il contratto ha una durata di tre anni e non prevede scatti stipendiali: la retribuzione resta fissa per l’intera durata del rapporto.
I professori associati godono invece di una progressione regolare: ogni due anni maturano uno scatto del 2,5% circa sulla retribuzione base, un piccolo incremento che nel lungo periodo incide positivamente sul reddito complessivo. Con il passare del tempo, questi aumenti permettono di consolidare il salario e di avvicinarsi alle soglie economiche della prima fascia.
Per i professori ordinari, la progressione è più marcata. Dopo sei anni di servizio, la retribuzione cresce in media di un 6%, mentre dopo dodici anni può arrivare a un aumento complessivo del 12% rispetto al valore iniziale.
Qualità del lavoro universitario: tra didattica, ricerca e carichi gestionali
Essere docente universitario in Italia significa svolgere una professione complessa e multidimensionale, dove didattica, ricerca e attività gestionale si intrecciano quotidianamente.

Le ore passate in aula rappresentano solo una parte del lavoro complessivo: dietro ogni corso ci sono mesi di preparazione, aggiornamento bibliografico, correzione di elaborati, organizzazione di laboratori e ricevimento degli studenti.
A queste si aggiungono le attività di ricerca scientifica, vero motore dell’università, che richiedono costante impegno in termini di progettazione, pubblicazioni e partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali.
La componente gestionale, spesso meno visibile, assorbe una quota crescente del tempo dei docenti. Riunioni di dipartimento, commissioni, valutazioni interne, rendicontazioni e rapporti con enti di finanziamento sono ormai parte integrante del mestiere accademico.
In molti casi, soprattutto per i professori associati e ordinari, le ore dedicate a compiti amministrativi finiscono per superare quelle destinate alla ricerca pura, riducendo il tempo disponibile per la produzione scientifica individuale.

Secondo le ultime rilevazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, un docente universitario dedica mediamente tra 1.500 e 1.800 ore di lavoro annue, ma solo una parte limitata (circa il 35-40%) è effettivamente riconosciuta come orario didattico ufficiale. Il resto si distribuisce tra studio personale, corrispondenza scientifica, gestione di progetti, tutoraggio, attività di terza missione (divulgazione e collaborazioni con enti pubblici o privati).
In questo contesto, la qualità del lavoro accademico dipende sempre più dalla capacità del docente di bilanciare compiti diversi: essere al tempo stesso insegnante, ricercatore e persino di manager, in un sistema che richiede efficienza ma offre risorse spesso limitate. È un equilibrio fragile ma fondamentale, perché proprio nella qualità di questo lavoro quotidiano, nella passione per l’insegnamento e nel rigore della ricerca si misura la forza e la credibilità dell’università italiana.
Riassumi con IA














I docenti universitari non ricevono la carta del docente. Questa è solo per gli insegnanti.
Grazie per la segnalazione, Simonetta! Provvederemo a correggere l’informazione al più presto.
Pazzesco che dei cervelli guadagnino una miseria e chi si mette in mostra in TV o tiri quattro calci ad un pallone guadagni soldi a palate. Vogliamo renderci conto che è la scienza che fa progressi e non le sciocchezze ?
Grazie per i dettagli. Manca una precisazione importantissima per fare i calcoli… si parla di netti o lordi??
La differenza è enorme…
Grazie mille!
Quelli riportati sono stipendi netti, se fossero lordi sarebbero inferiori a quelli di un insegnante delle scuole secondarie. Una cosa rilevante che non è riportata è l’attività di ricerca, intesa anche come richiesta di finanziamenti, organizzazione degli esperimenti scientifici, stesura di articoli. Quest’ultima parte per i docenti di alcune facoltà occupa più del 50% del tempo.
Un’altra precisazione da fare è che l’attività gestionale per alcuni docenti è davvero rilevante. Alcuni professori (sia associati che ordinari) gestiscono gruppi di ricerca e pagano stipendi a 10-20 persone; un’attività che come complessità si può paragonare a quella della gestione di una piccola impresa.
Un’altra precisazione da fare è che, nonostante la notevole disparità stipendiale, gli incarichi di professori associati e ordinari sono esattamente gli stessi. Anzi molto spesso alcuni associati hanno un carico ampiamente superiore a quello dei colleghi ordinari. Infatti nell’Università italiana la retribuzione non è minimamente legata al carico didattico, di ricerca o gestionale. Speriamo che in futuro lo stipendio venga determinato dalle effettive mansioni svolte dal docente, dalla sua ‘produttività scientifica’, dalla sua performance nell’insegnamento e da altri parametri oggettivi.
Grazie Stefano per le precisazioni, le terremo presenti per aggiornare l’articolo!
Articolo scritto con i piedi da chi di università non conosce nulla. In più descrive, male, regole ormai superate
Ciao Francesco,
ci dispiace che l’articolo non ti sia sembrato all’altezza, anche se definirlo “scritto coi piedi” ci sembra un po’ eccessivo. Prendiamo sul serio i tuoi commenti e ci impegniamo a migliorare continuamente i contenuti che offriamo. L’articolo è stato aggiornato di recente, ma verificheremo di nuovo le informazioni per assicurarci che tutto sia corretto e aggiornato.
Grazie per il tuo feedback, ci aiuta a fare meglio!
Articolo interessante ed esaustivo mi ha chiarito tanti aspetti della mi a vita ed eventuali prospettive future.
L altro aspetto da considerare che è un lavoro da fare in equipe, e che può essere molto stressante in quanto competitivo,
Grazie mille per il tuo feedback! 😊 Sono felice che l’articolo ti sia stato utile per riflettere sulla tua vita e sulle tue prospettive future. Hai ragione a sottolineare che lavorare in équipe può essere stressante, soprattutto in contesti competitivi, ed è una differenza importante rispetto al mestiere di insegnante. Se hai altre riflessioni o domande, siamo qui per discuterne!
Abbastanza chiaro ma ci sono alcune inesattezze che dovrebbero essere corrette. Prima fra tutti: non esiste più la figura del ricercatore confermato, da una decina di anni e forse più, sarebbe il caso di correggere. Ii percorso del ricercatore, con la nuova legge in vigore, è una tenure track che permette di accedere al ruolo di professore sssociato dopo 3 snni se nel frattempo si è ottenuta l’abilitazione nazionale di docente di seconda fascia. Se non la si ottiene, dopo 5 anni si è totalmente fuori dai giochi. Anche per partecipare a concorsi da ordinario è necessaria l’abilitazione nazionale di docente di prima fascia (non è richiesto per un associato avere totalizzato 350 ore di lezione da raggiungere, come dichiarato nel testo). Gli importi stipendiali dichiarati sono molto verosimili. Prima di ricercatore tenure track edistono altre posizioni temporanee genericamente indicste come post doc. La carta docente non è usufruibile da parte dei docenti universitari, a meno che non abbiano cambiato la legge da pochissimo. (Mi sono permesso di correggere per esperienza diretta, dato che sono un docente universitario).
Grazie infinite per il tuo commento Valter! Abbiamo fatto tesoro delle tue osservazioni e corretto le informazioni datate o inesatte contenute nell’articolo. Il tuo contributo è stato davvero prezioso, grazie per averci aiutato a migliorare! 😊
I docenti universitari non usufruiscono drlla Carta del docente.
Grazie Fabio, abbiamo provveduto a correggere l’informazione 😊!
Se pagano così poco i ricercatori, a chi vanno tutte le offerte?
Ciao! Hai ragione, il tema della retribuzione dei ricercatori universitari è molto delicato 😕 Purtroppo i fondi disponibili spesso non bastano a garantire stipendi adeguati, soprattutto nelle prime fasi della carriera. Le risorse vanno a coprire molte voci, dalla didattica alla gestione delle strutture, e alla fine a rimetterci sono proprio i giovani ricercatori. Un vero peccato per un settore così strategico!