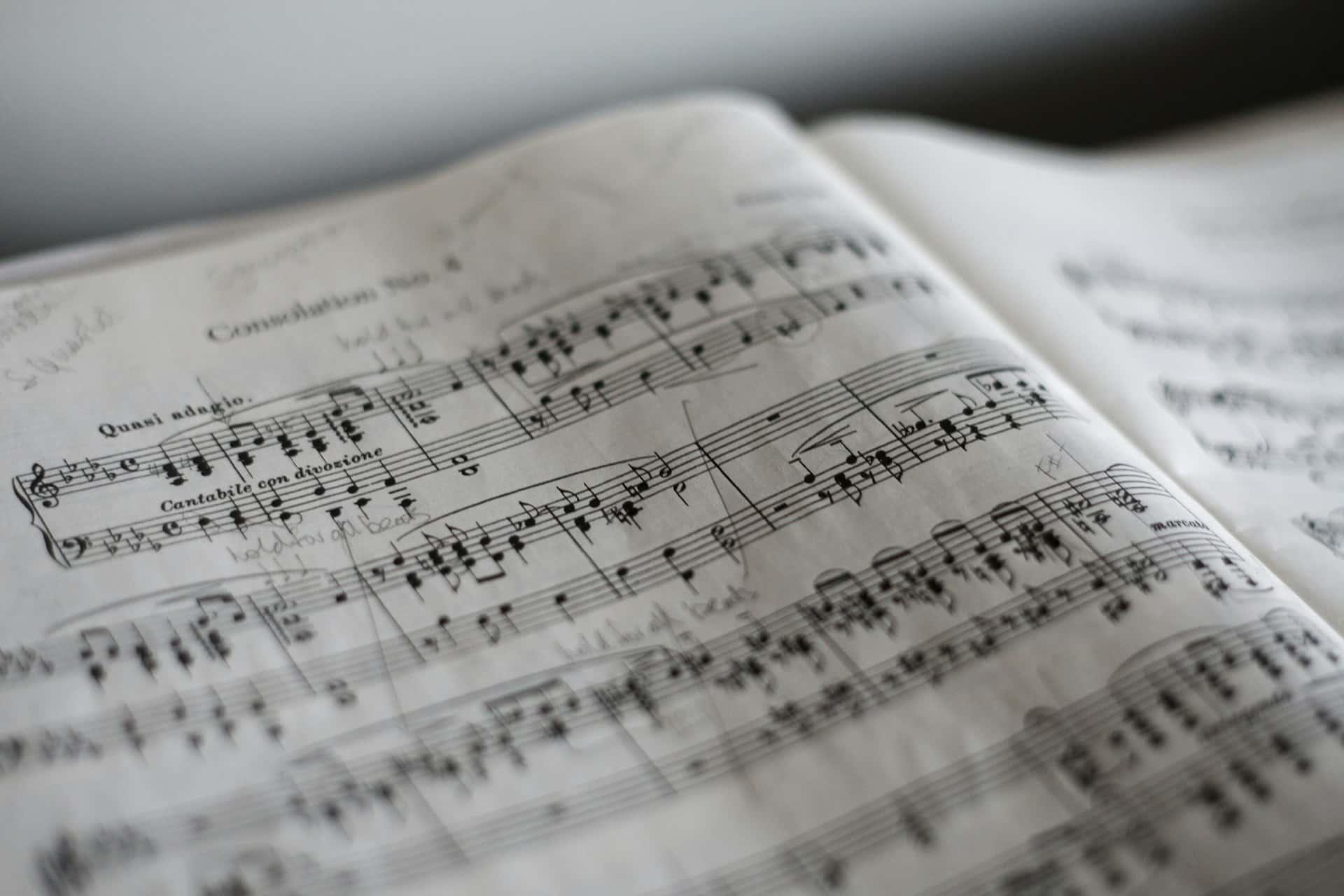La musica è matematica, ma la matematica non basta a spiegare la musica.
Tiziano Terzani
Il rapporto tra la matematica e la musica è stato riconosciuto fin dall’antica Grecia, quando Pitagora iniziò a misurare il suono e i suoi intervalli, rendendosi conto che erano basati su proporzioni precise.
La matematica è una forma d'arte e per Pitagora e i suoi seguaci, la musica fu il punto di partenza per sviluppare le proprie conoscenze matematiche: per loro la musica era una forma sonora di aritmetica e geometria. Platone e altri filosofi associarono alla musica il suono dei sette pianeti, accostandola a un’altra scienza, l’astronomia.
La musica quindi, al pari di astronomia, aritmetica e geometria è stata per secoli una delle conoscenze fondamentali con cui l’umanità ha cercato di comprendere ed esprimere l'armonia dell'universo.
Dalle scale pitagoriche, alla teoria musicale come la conosciamo oggi ai prodotti musicali considerati commerciali, nessuno nega che fare musica richieda non solo creatività, ma una profonda conoscenza del suo linguaggio e delle sue tecniche che sono anche matematici.
I grandi nomi della musica classica come Back e Mozart e i tormentoni estivi, a loro modo, hanno saputo mettere nero su bianco il legame tra le note e i numeri.
In questo articolo vedremo perché la musica e la matematica sono tanto legate l’una all’altra.

Struttura delle scale musicali: dalla scala pitagorica a Bach
Le note musicali che adottiamo oggi, do, re, mi. fa, sol, la, si, do, corrispondono a suoni armonici prodotti da corpi elastici, come le corde, e distanti tra loro secondo un numero specifico di vibrazioni, le frequenze.
La successione di queste note nella teoria musicale è la scala e quella che adottiamo oggi si chiama scala diatonica, dove l'ultima nota, l'ottava è una ripetizione della prima.
L’ottava è l'intervallo tra due suoni, dove il più acuto ha il doppio delle vibrazioni della prima nota. Più si sale sulla scala, più la nota diventa acuta.
L’intervallo è la differenza di vibrazioni tra due note e ne misura la distanza.
Nel corso della storia della musica occidentale sono state usate la scala pitagorica, la scala naturale del pitagorico Archita e ripresa dal musicista francescano Gioseffo Zarlino.
A queste sono seguite le scale temperate, come quella creata da Andreas Werckmeister alla fine del 1600 e portata al successo dal compositore Johann Sebastian Bach, che risolse diversi problemi di stonatura tra gli intervalli.
Ma come siamo arrivati alle scale musicali? Dalla matematica, studiata durante l'ora di ripetizione matematica roma!
La matematica delle scale musicali
Si narra che lo studio della musica come matematica lo si deve a Pitagora (Samo 570 a.C. - Metaponto 490 ca a.C). Lo studioso greco si rese conto che alcuni suoni risultavano piacevoli all’orecchio e provò a identificarli pizzicando una corda tesa a metà della sua lunghezza, in tre parti uguali e quattro parti uguali.

Pitagora chiamò questi suoni piacevoli consonanti e ne individuò sette che erano distanti tra di loro secondo un rapporto costante, geometrico.
Pitagora, creò la prima scala musicale, utilizzata in Occidente, partendo dall’osservazione che un suono è direttamente proporzionale alla radice quadrata della tensione di una corda, e inversamente proporzionale alla lunghezza della corda.
Anche la concezione estetica dell'antica Grecia era fondata sul principio di costanza, proporzione: per questo anche matematica e architettura sono legate.
Per Pitagora i suoni naturalmente accettati dall’orecchio come piacevoli e quindi consonanti, davano vita all'armonia e si facevano:
Suonando insieme una corda di lunghezza L e una di 1/2 di L (Do= intervallo di ottava)
Suonando insieme una corda di lunghezza L e una di 2/3 di L (Sol= intervallo di quinta)
Questo sistema musicale delle consonanti della scala pitagorica rimase in vigore fino al XVI sec. quando si iniziò a mettere in dubbio la precisione degli intervalli tra le frequenze del suono, ossia le note, identificate dal matematico greco e dai suoi seguaci.
Il temperamento nella teoria musicale
Per quanto avesse individuato delle proporzioni chiare, la scala pitagorica non era perfetta e nel corso del tempo fu inserito il temperamento, un aggiustamento tra le note musicali.
Temperamento di Gioseffo Zarlino (1571-1590)
Temperamento di Vincenzo Galilei (1520-1591)
Temperamento di Werckmeister (1645-1706)
La musica è un esercizio occulto dell’aritmetica, nel quale la mente non si rende conto di calcolare
Leibinz
A questo esercizio occulto, i maggiori matematici della storia cercano di dare una risposta, usando i logaritmi per calcolare gli intervalli delle note con più precisione rispetto alla scala pitagorica.
Keplero, Cartesio, Eulero contribuirono tutti alla nascita della teoria musicale tendando di risolvere matematicamente i problemi di notazione musicale.
L’ottava viene ripartita in 12 parti uguali, i semitoni.
Johan Sebastian Bach
La ricerca dell’ordine nella musica, spinse uno dei compositori più grandi della storia, Johann Sebastian Bach e il suo “Clavicembalo ben temperato” a fare dei concetti matematici di simmetria, sezione aurea la base delle sue celebri composizioni.

I pattern matematici di Bach
Nonostante il superamento della scala pitagorica, in qualche modo Bach e i musicisti che entrano a far parte della Società per le Scienze Musicali, cercano di riportare la musica alla matematica e più in generale al concetto di armonia universale che le era stata attribuita da Pitagora e seguaci.

Gli intervalli tra le note sono delle grandezze numeriche precise e se la musica è numero, tutto è numero, l’universo è numero e quindi armonia.
È in questo quadro che Bach compone L’Arte della Fuga, un componimento incentrato sui numeri cari a Pitagora, 1,2,3 e 4 che formano il triangolo perfetto. In totale le fughe sono 14, un numero quasi mistico per Bach.
Anche la musica moderna segue una chiara struttura, i pattern ritmici, che danno il ritmo alle canzoni e le rendono orecchiabili. La ripetizione e la prevedibilità della successione di suoni e silenzi in strutture ben congegnate, i pattern, determinano il successo, e a volta l'avversione, per i famosi tormentoni.
La sezione aurea in Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) il bambino prodigio della musica, era un altro grande appassionato di numeri. Nel Don Giovanni si cantano i numeri delle conquiste del protagonista, “In Italia seicento e quaranta , in Alemagna duecento e trentuno..." ma non solo.
In quest’opera troviamo un esempio della grande regolarità matematica delle opere di Mozart, quando un minuetto in 3/4, una contraddanza in 2/4 e un’allemanda in 3/8 vengono suonati contemporaneamente.
L’ordine e la precisione che trasmettono la musica di Mozart sono esattamente l’ordine e la calma ricercati dai pitagorici nella matematica.

Il compositore austriaco si spinge oltre e prende un celebre rapporto matematico, la sezione aurea, come canone per la composizione delle sue opere.
Oltre a indicare lo stretto rapporto che c’è tra la matematica e la pittura, la sezione aurea ne sancisce anche il rapporto con la musica.
La sezione aurea è una proporzione secondo cui un segmento può essere diviso in due parti disuguali in modo che il rapporto tra l’intero segmento e la parte maggiore sia lo stesso tra la parte maggiore e quella minore.
Il rapporto aureo, phi, è pari a 1,618. Ebbene, nelle 19 sonate per pianoforte di Mozart il rapporto tra il numero delle battute delle diverse sezioni dei componimenti è pari proprio a 1,618.
In molti si sono cimentati ad analizzare le opere di Mozart con moderni software per individuarne i pattern matematici e la sezione aurea sembra ben presente.
Fibonacci e musica
Puoi parlare di sezione aurea durante il tuo corso di matematica: è impossibile non far riferimento alla sequenza di Fibonacci, un elenco di numeri in cui il successivo è pari alla somma dei primi due, insomma una sezione aurea aritmetica.

Non solo Mozart, ma anche altri grandi compositori hanno inglobato il rapporto aureo e la sequenza di Fibonacci nelle loro opere:
- Beethoven
- Bartók
- Debussy
- Schubert
- Satie
La serie di Fibonacci sembra avere una particolare presa sul compositore ungherese Béla Bartók che la utilizza in maniera estensiva in tutte le sue opere.
Tra i cantanti moderni possiamo citare i Genesis e le battute dei loro assoli che seguono la sequenza di Fibonacci, senza dimenticare il rock dei Deep Purple o Dream Theater. Cosa ne pensa il tuo insegnante di ripetizione matematica milano?
La matematica nella musica: conclusioni
Fin dall’antichità gli esseri umani hanno scoperto la correlazione tra la matematica e la musica. In particolare, Pitagora, l’ideatore della matematica, notò alcuni suoni percepiti dall’orecchio come piacevoli avevano un rapporto costante tra loro.
Empiricamente Pitagora elaborò la prima scala musicale, la scala diatonica pitagorica formata da sette note prima di arrivare all’ottava che era uguale alla prima ma acuta. A partire dalla prima nota, Pitagora aveva ricavato el altre suddividendola in 2, 3 o 4 parti.

La distanza tra gli intervalli prevedeva anche alcune stonature, per questo matematici e musicisti nel corso della storia hanno studiato dei temperamenti che aiutassero a migliorare le proporzioni.
Archita, discepolo di Pitagora, e nel 1588 Gioseffo Zarlino, divisero l’ottava in numeri diversi da quelli di Pitagora: la corda venne suddivisa anche per i numeri 5 e 6.
Neanche questa scala era perfetta per cui furono inseriti dei temperamenti fino ad arrivare a dividere l’ottava per 12, dando origine alla scala che usiamo oggi.
Bach fu la massima espressione di questa nuova scala, ma non dimenticò l’importanza dei numeri di Pitagora, tanto da includere il 4 e il 14 nei suoi componimenti.
Molti musicisti hanno continuato a usare la matematica per comporre opere straordinarie che sembrano parlare all’universo, seguendo i principi del rapporto aureo o la sequenza di Fibonacci. Tra questi spiccano Mozart, Beethoven, Bartók. Lo stesso hanno fatto diversi scrittori mostrando che c'è uno stretto legame anche tra matematica e letteratura.
Non solo la musica classica ma anche la musica rock incorpora i principi matematici, mentre la musica commerciale usa i concetti di ripetizione di partner ritmici per sfornare le hit.
Il legame tra matematica e musica è indissolubile e con le nuove scoperte dell’IA, potrebbe diventare ancora più stretto.
Résumer avec l'IA :