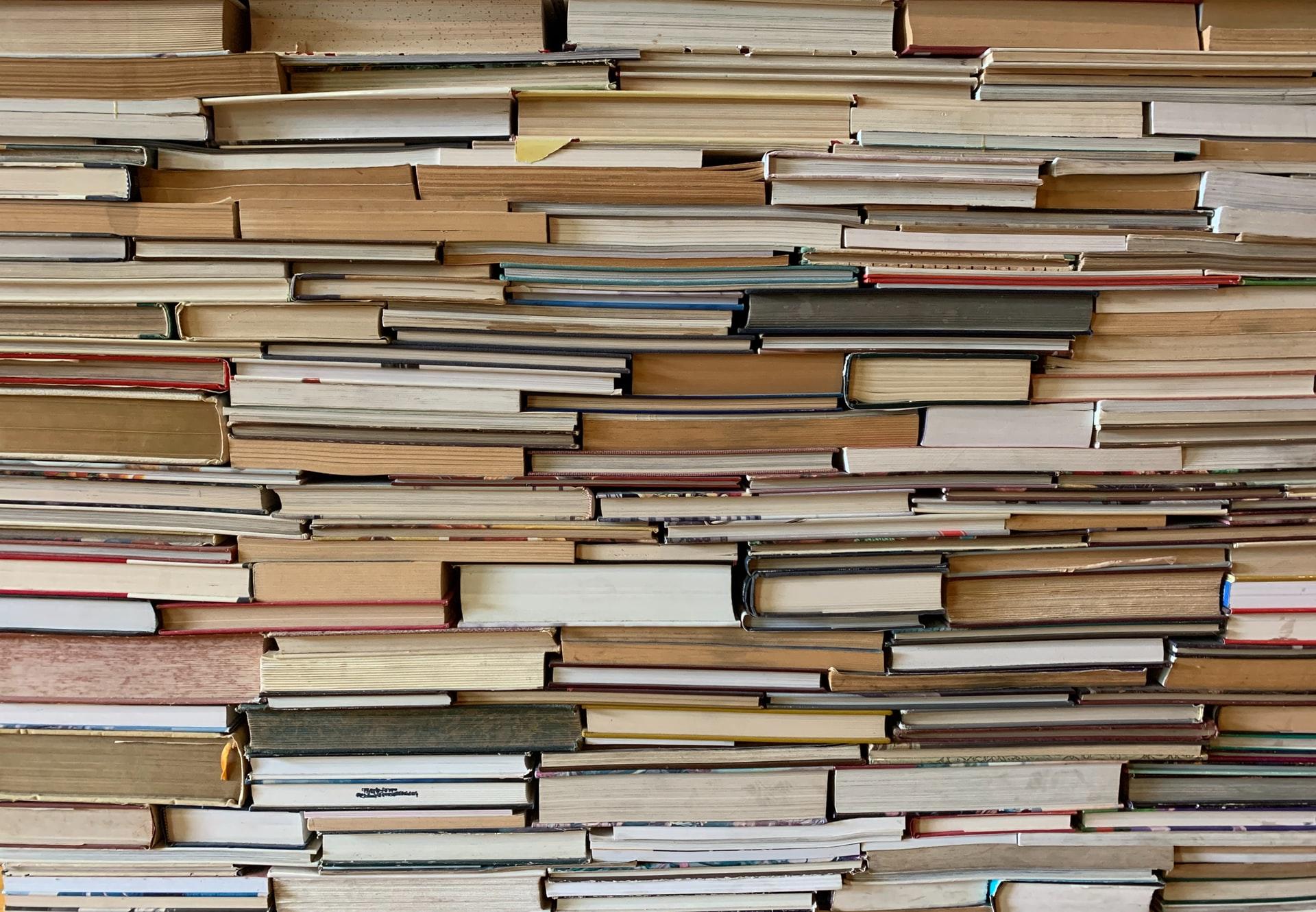Secondo recenti indagini condotte dall’Istat circa un italiano su due parla ancora una lingua regionale (o “dialetto”). Va però sottolineato che l'uso esclusivo delle lingue regionali è certamente diminuito rispetto ai primi dati disponibili (primi anni ’70 del XX secolo), e il loro utilizzo riguarda principalmente gli scambi comunicativi che avvengono nel contesto familiare e amicale.
Dal punto di vista linguistico il panorama italiano è sempre stato estremamente vario e complesso: per moltissimo tempo non è esistita una lingua “comune”propriamente detta, pertanto le persone hanno utilizzato la propria lingua locale. Purtroppo, per ragioni molteplici, si è giunti a considerare i dialetti come un tratto culturale ormai passato della cultura italiana, associati a un mondo destinato a scomparire.
Tuttavia la consapevolezza della necessità di preservare e conservare il nostro prezioso patrimonio linguistico oggi è sempre più diffusa, e nel corso dei decenni sono state portate avanti iniziative a livello locale, regionale e nazionale per promuovere lo studio e la conservazione delle lingue regionale.
In questo articolo scopriremo perché i dialetti sono stati e sono ancora così importanti oggi per comprendere la cultura italiana!

La mappa dei dialetti italiani
Nel corso dei secoli che hanno preceduto l’unità d’Italia le persone che abitavano la penisola italiana erano solite parlare il proprio vernacolo locale. Questi vernacoli, o dialetti, si sono storicamente evoluti dal latino volgare nel corso dei secoli e non sono dunque varianti dell'italiano standard, ma sono a tutti gli effetti “lingue sorelle” dell'italiano. I dialetti possono differire molto dall'italiano, a livello morfologico, sintattico e lessicale, e per tale motivo sono classificate come lingue distinte.

La lingua che noi oggi definiamo “italiana” si è sviluppata in Toscana ed è stata formalizzata all'inizio del XIV secolo attraverso le opere di Dante Alighieri, scritte in fiorentino, il quale divenne la base di ciò che sarebbe diventata la lingua ufficiale dell'Italia molti secoli dopo, quando nel nascente Regno d'Italia si palesò la necessità di individuare una lingua comune capace di facilitare le comunicazioni tra le varie regioni d'Italia.
Ma quali sono i dialetti italiani?
In generale possiamo identificare tre macro gruppi di dialetti (e lingue parlate da minoranze linguistiche):
- Dialetti e lingue parlati nell’Italia settentrionale [patois, provenzale, piemontese, ligure, lombardo, emiliano, romagnolo, veneto, walser, tedesco,ladino, friulano, sloveno]
- Dialetti parlati nelle aree centrali e meridionali d’Italia [toscano; meridionali (marchigiano, umbro, laziale, romanesco, aquilano); meridionali intermedi (ascolano, abruzzese, molisano, campano, lucano, foggiano barese, tarantino, calabrese settentrionale); meridionali estremi (salentino, cosentino, catanzarese, reggino, siciliano); arbëresh, grecanico]
- Dialetti e lingue parlate in Sardegna [sassarese/gallurese, logudorese-campidanese; catalano]
L’importanza dei dialetti in Italia
Nell’Italia contemporanea i dialetti vengono parlati perlopiù in contesti informali, e la loro forza espressiva e il loro lessico puntuale e "ficcante "colorito" sono senza dubbio due delle ragioni che ne giustificano il grande utilizzo ancora oggi.

Purtroppo l’utilizzo dei dialetti è stato stigmatizzato per decenni, principalmente per ragioni legate a una erronea percezione di scarso prestigio sociale: l’utilizzo del dialetto è stato infatti storicamente associato al mondo contadino e a quelle realtà di povertà, difficoltà economica e scarsa scolarizzazione che caratterizzarono il secondo dopoguerra. Il dialetto, insomma, era considerato "cosa da ignoranti", da relegare aun passato considerato chiuso e superato.
Questa visione però non ha impedito ai dialetti di continuare a svolgere un ruolo centrale nella vita degli italiani, che hanno (fortunatamente!) continuato a utilizzarli in vari contesti sociali.
Secondo i linguisti e gli studiosi di cultura italiana i dialetti non dovrebbero quindi essere tralasciati e considerati come un fenomeno culturale retrivo e da relegare al passato, bensì come un tratto caratteristico della cultura e della vita quotidiana degli italiani.
Cibo, dialetti e identità
Senza dubbio uno degli aspetti più distintivi e caratteristici della cultura italiana è la cucina: nota in tutto il mondo per la sua varietà, la cucina italiana è un complesso “patchwork” di tradizioni locali e regionali.

Dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, dalla Calabria al Friuli Venezia Giulia, la tradizione culinaria italiana è caratterizzata da migliaia di espressioni e di modi dire dialettali, i quali esprimono tutta la ricchezza del patrimonio linguistico e culturale di ogni singola regione d’Italia.
Come potremmo infatti parlare di tradizione enogastronomica italiana senza utilizzare le parole e i modi di dire dialettali e regionali in cui tale tradizione si esprime?
I dialetti nella letteratura
Nel corso della storia della letteratura italiana moltissimi autori hanno impiegato un vernacolo all’interno delle proprie opere.
Quando, nel corso del Rinascimento, il toscano assunse il ruolo di lingua letteraria presso le corti e presso i circoli di intellettuali di tutta Italia, le lingue locali vernacolari poco per volta videro erodersi perdere il proprio prestigio culturale e letterario, venendo “declassate” al rango di dialetti.
Ovviamente i vernacoli continuarono a esistere e a essere impiegati nella vita quotidiana e in letteratura, ma la produzione letteraria vernacolare perse progressivamente importanza, arrivando a essere considerata una “letteratura minore”.

Ma quali furono gli autori che nel corso dei secoli continuarono a utilizzare il dialetto?
Praticamente tutti i grandi della letteratura italiana! Dante, Bembo, Goldoni, Pasolini... sono tantissimi gli autori che nel corso dei secoli hanno utilizzato uno o più dialetti nelle proprie opere.
I dialetti sono stati utilizzati dai grandi letterati per la loro forza espressiva e per la maggiore ricchezza del loro lessico: spesso i vernacoli donano a un’opera una maggiore vivacità, offrendo la possibilità di utilizzare contemporaneamente più registri linguistici e di rappresentare in modo più vivido , realistico ed efficace i personaggi.
Il cinema italiano e l’uso dei dialetti
Un corso italiano online non può non trattare almeno in parte del ruolo del cinema nella formazione linguistica degli italiani! Il cinema italiano ha avuto sempre un rapporto un po' difficile con i dialetti. In origine i dialetti sono stati impiegati utilizzati con una certa frequenza; in seguito, per via delle politiche repressive del regime fascista, fu imposto l’uso dell’italiano standard, il quale era considerato uno strumento essenziale per la creazione di un’identità nazionale unitaria. In questo processo di standardizzazione linguistica i dialetti iniziarono a essere utilizzati nel cinema in modo sempre più caricaturale, giungendo a quella “tipizzazione” stereotipata delle identità e delle parlate regionali che diventerà un caposaldo di tanta produzione comica della commedia all’italiana.

Una fulgida eccezione è rappresentata dal cinema neorealista del secondo dopoguerra e da registi come De Sica e Rossellini: grazie ai loro capolavori dialetti tornarono ad avere un ruolo importante nella rappresentazione dei personaggi appartenenti al popolo, rappresentati in modo realistico e assolutamente non caricaturale.
Hai provato a digitare la richiesta "cercasi insegnanti di italiano"? Potresti appassionarti allo studio della lingua, come mai hai fatto prima!
La sfida del futuro: conservare il patrimonio linguistico regionale
Le trasformazioni radicali avvenute negli ultimi decenni, con la crescente globalizzazione culturale e con il veloce ricambio generazionale, rappresentano una minaccia reale per la sopravvivenza e per la salvaguardia del patrimonio linguistico regionale italiano.
Per fortuna esistono molte realtà locali e regionali impegnate nella conservazione del patrimonio linguistico regionale, il cui lavoro congiunto permette alle lingue locali di sopravvivere e di incontrare un maggiore riconoscimento istituzionale e culturale.
Questo grande lavoro di conservazione e recupero dei dialetti è soprattutto finalizzato alla diffusione di una maggiore consapevolezza del patrimonio linguistico regionale d’Italia, che sempre di più andrà protetto e valorizzato, soprattutto dalle nuove generazioni.
Riassumi con IA