La letteratura italiana, ossia il corpus di opere scritte prodotte in lingua italiana, ebbe inizio nel XIII secolo. Fino a quel momento infatti quasi tutte le opere letterarie composte in Europa durante il Medioevo erano scritte in latino.
Sono giunti a noi solo brevi ed esigui frammenti di versi in volgare italiano prima della fine del XII, e i versi sopravvissuti del XII e XIII secolo mostrano una certa influenza francese e provenzale. L’italiano come lingua letteraria deve le sue origini all'ambiente colto della corte siciliana dell'imperatore Federico II, che governò il regno siciliano dal 1208 al 1250, sotto la cui egida furono scritte liriche modellate su forme e temi provenzali in una raffinata versione del volgare siciliano locale.
La poesia siciliana continuò ad essere scritta dopo la morte di Federico II, ma il centro dell'attività letteraria si spostò in Toscana, dove l'interesse per la lirica provenzale e siciliana aveva portato a numerose imitazioni da parte di Guittone d'Arezzo e dei suoi seguaci. Nacque così la scuola toscana,vera e proprio fucina creativa della prima letteratura italiana, la quale diede il via a una tradizione ininterrotta costellata di grandi capolavori apprezzati in tutto il mondo!
In questo articolo, come in tutti i corsi di italiano firenze o roma, scopriremo alcuni tra i più importanti autori della letteratura italiana di tutti i tempi: Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Italo Svevo ed Elsa Morante. Buona lettura!

Dante Alighieri
Dante Alighieri (1265-1321) è universalmente riconosciuto come il più celebre e influente poeta della letteratura italiana e tra i più importanti autori della letteratura europea. Autore raffinato e poeta sopraffino, Dante scrisse opere in prosa, poemi, testi di critica letteraria, di filosofia morale e di politica. Dante ha prodotto uno dei corpus letterari più ampi e amati- di tutta la letteratura mondiale.

Dante Alighieri è universalmente noto per la Commedia, in seguito appellata da Giovanni Boccaccio La Divina Commedia, pietra miliare della letteratura italiana e certamente una delle più grandi opere di tutta la letteratura medievale europea.
In quest’opera viene offerta una visione cristiana del destino terreno e spirituale dell'umanità, visione profondamente influenzata dall'esperienza dell'esilio vissuta dal poeta fiorentino. La Divina Commedia stupisce ancora oggi per la sua vastità tematica, per la sua analisi acuta e approfondita della situazione socio-politica dell’Italia medievale e per la ricchezza del linguaggio e delle immagini utilizzate.
La scelta di scrivere la sua opera più importante in volgare e non in latino influenzò in modo profondo la storia dello sviluppo letterario della lingua italiana, che proprio nell’opera di Dante trova una delle sue più compiute e mirabili espressioni.
Al tempo di Dante visse una personalità di spicco della scena intellettuale fiorentina, Brunetto Latini, il quale seppe risvegliare una nuova coscienza pubblica nelle figure intellettuali di spicco della nuova generazione, tra cui Guido Cavalcanti, Forese Donati e lo stesso Dante, incoraggiandoli a mettere la loro conoscenza e la loro abilità di scrittori al servizio della loro città. Dante ne fu allievo e da lui imparò l’idea della gloria imperitura ottenuta attraverso la propria opera letteraria, idea che attraverserà tutta la produzione di Dante, e in particolar modo la Divina commedia.
La Divina Commedia
La Divina Commedia, come si apprende ai corsi di italiano milano, è un poema narrativo composto in terza rima tra il 1308 e il 1321, poco prima della morte dell'autore. L’opera è composta da 14.233 versi suddivisi in tre cantiche- Inferno, Purgatorio, Paradiso- ciascuna composta da 33 canti. Un canto iniziale, che serve da introduzione al poema e generalmente considerato parte della prima cantica, porta il numero totale di canti a 100.
La Commedia descrive il viaggio di Dante attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso guidato prima dal poeta romano Virgilio e poi da Beatrice, la donna da lui platonicamente amata per tanta parte della sua vita.
Scritta in prima persona, la Commedia racconta il viaggio di Dante attraverso i tre “regni dei morti”, durato dalla notte precedente al Venerdì Santo sino al mercoledì successivo alla Pasqua nella primavera del 1300. Il poeta romano Virgilio lo guida attraverso l'Inferno e il Purgatorio, mentre Beatrice, la donna ideale (e idealizzata) di Dante, lo guida attraverso il Paradiso.
Con la sua serietà di intenti, la sua statura letteraria e la varietà stilistica tematica del suo contenuto, la Divina commedia divenne sin da subito una pietra miliare della nascente letteratura italiana e dell'italiano come lingua letteraria. In tal senso Dante fu senza dubbio un precursore del Rinascimento, con il suo sforzo di creare una letteratura volgare capace di confrontarsi in statura e profondità con la letteratura classica.
Giovanni Boccaccio
Il nostro corso italiano continua con Giovanni Boccaccio (1313–1375): è stato uno scrittore, poeta e umanista italiano, considerato una delle figure più importanti nel panorama letterario europeo del Medioevo.

Boccaccio è stato uno scrittore originale e fantasioso, capace di unire tematiche e generi letterari diversi, dando vita a testi unici e affascinanti. Insieme a Dante e Petrarca è da sempre considerato uno dei padri della nascente letteratura italiana. Boccaccio fu figlio di un commerciante toscano e di madre francese; il padre inviò il giovane figlio a Napoli, dove Giovanni ebbe modo di entrare in contatto con l'aristocrazia e con il mondo commerciale. Questa esperienza influenzò enormemente la sua opera letteraria.
I temi della cavalleria e dell'amor cortese erano da tempo celebri e molto amati negli ambienti di corte, ma Boccaccio seppe arricchirli con la sua capacità di osservazione della vita reale, presentando tematiche nuove e “moderne” con grande competenza retorica, , in modo tale da rendere il suo linguaggio degno di essere accostato ai grandi classici della cultura classica. Fu proprio Boccaccio infatti a donare dignità all'ottava rima, il metro dei menestrelli popolari, che diventerà il metro caratteristico della poesia italiana nei secoli a venire.
Boccaccio scrisse il suo capolavoro, il Decameron, tra il1348 e il 1353: quest’opera è in assoluto il punto più alto della sua produzione letteraria, ed è unanimemente considerato il capolavoro fondante della prosa in lingua italiana, presa a modello da tutti gli autori successivi.
Il Decameron
Il Decameron narra della fuga di dieci giovani da Firenze, tragicamente colpita dalla peste del 1348. I giovani trovano rifugio preso una residenza di campagna, dove, per quindici giorni, ogni membro del gruppo a turno avrà il compito di decidere nei dettagli come trascorrere la giornata e soprattutto avrà il compito di raccontare delle storie. Questi racconti occupano dieci giorni della struttura dell’opera: Decameron infatti significa"Dieci giorni/(Opera di) dieci giorni".
Le prefazioni alle giornate sono basate su temi e stilemi di matrice classica, caratterizzati da un lessico raffinato e da periodi molto complessi. Boccaccio fu però un vero maestro della parola parlata e della narrazione libera e vivace, capace di traslare l’eloquio comune in bellissima prosa avvincente.
Questi due aspetti della scrittura di Boccaccio fanno del Decameron il grande classico della prosa letteraria italiana e un classico di ogni corso italiano.
Ludovico Ariosto
Ludovico Ariosto (1474-1533) è stato un dei più importanti autori italiani del Rinascimento. Noto principalmente per il suo celebre Orlando furioso, prosecuzione ideale dell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, Ariosto è da sempre considerato uno dei padri nobili della letteratura italiana.
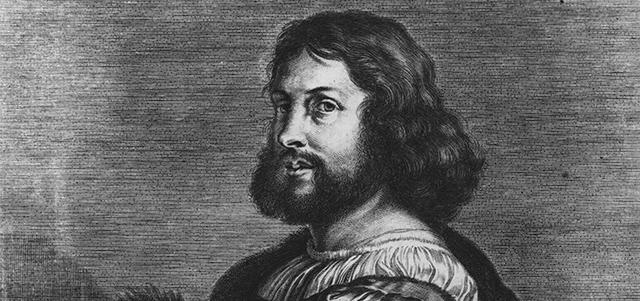
L’opera è una satira della tradizione cavalleresca ed è interamente costruito su una sequela di episodi tratti dall'epica, dai romanzi e dalla poesia eroica del Medioevo e del primo Rinascimento. L’opera di Ariosto è considerata come la massima espressione della letteratura e del pensiero rinascimentale italiano, e a lui dobbiamo inoltre l’introduzione del termine "umanesimo", con il quale egli intendeva descrivere e rinforzare l’importanza delle forze e delle capacità dell'essere umano.
L’Orlando furioso
Un corso di italiano per italiani; l’Orlando furioso è una continuazione del romanzo incompiuto di Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato (1495). L’opera è divisa in quarantasei canti, ciascuno contenente un numero variabile di strofe di otto versi in ottava rima, metro già utilizzato in opere precedenti quali il Morgante di Luigi Pulci e l’Orlando Innamorato di Boiardo. L'opera di Ariosto è inoltre una delle più lunghe della letteratura europea.
Nella sua ambientazione storica e nei suoi personaggi l’opera di Ariosto condivide alcune caratteristiche con la Chanson de Roland (XI secolo): la storia è infatti parte di una tradizione cavalleresca iniziata nel tardo Medioevo e che ha continuato a essere popolare nei secoli XVI e XVII.
Orlando è un cavaliere cristiano conosciuto in francese come Roland: la storia si svolge sullo sfondo della guerra tra i paladini cristiani di Carlo Magno e l'esercito saraceno che invase l'Europa nel tentativo di rovesciare l'impero cristiano. L’opera di Ariosto parla di guerra, di amore e dell'ideale romantico del mondo cavalleresco, mescolando realismo e fantasia, umorismo e tragedia.
Molti temi si intrecciano nella sua complicata struttura episodica, ma i più importanti sono certamente l'amore non corrisposto del paladino Orlando per la principessa pagana Angelica e l'amore tra la guerriera cristiana Bradamante e il saraceno Ruggiero, che si sostiene siano gli antenati dei mecenati dell'Ariosto, gli Este di Ferrara.

Torquato Tasso
Torquato Tasso (1544-1595) è stato un poeta italiano del XVI secolo, celebre per la sua poderosa opera, la Gerusalemme Liberata, in cui viene narrata una versione poetica e fantasiosa dei combattimenti tra cristiani e musulmani alla fine della prima crociata, durante l'assedio di Gerusalemme del 1099.
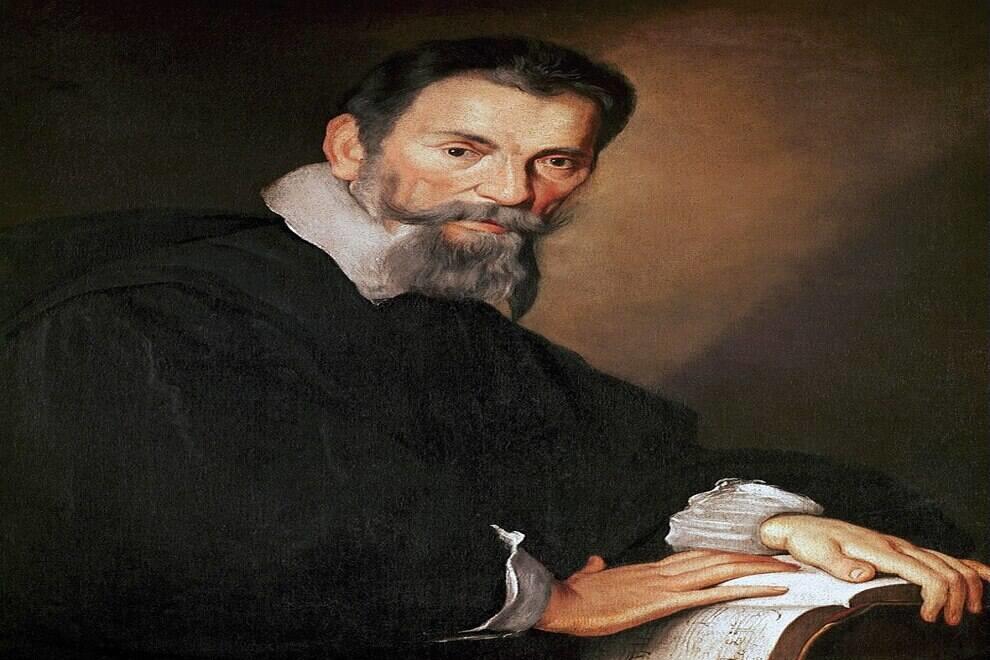
Il suo lavoro è stato ampiamente tradotto, letto e rielaborato fino all'inizio del XX secolo: il poema ebbe un enorme successo in tutta Europa e nei due secoli successivi alla pubblicazione varie sezioni della Liberata furono spesso adattate come trame individuali per madrigali, poemi, opere teatrali, balletti e mascherate.
Torquato Tasso ebbe una vita tormentata e difficile, minata da gravi disturbi mentali e da sorprendenti rovesci di fortuna, nonostante le sue opere conobbero un successo clamoroso quando l’autore era ancora in vita.
La Gerusalemme liberata
La Gerusalemme liberata è un poema epico eroico composto in ottava rima ed è considerato universalmente il capolavoro di Torquato Tasso. L’autore completò l’opera nel 1575 e poi trascorse diversi anni a rivederla e a rielaborarla. Mentre Tasso fu rinchiuso nel manicomio di Santa Anna una parte del poema fu pubblicata a sua insaputa. L’autore pubblicò infine la versione completa nel 1581.
Il poema racconta delle difficoltà iniziali e delle battute d'arresto dei cristiani e il loro successo finale nella presa di Gerusalemme nel 1099. I principali protagonisti storici della Prima Crociata sono presenti, ma gran parte dell’opera si occupa di sottotrame romantiche che coinvolgono personaggi completamente immaginari, ad eccezione di Tancredi, identificato con l’effettivo Tancredi, principe di Galilea.
Il Tasso cercò di bilanciare le aspirazioni morali dell'epoca con la propria ispirazione sensuale e le regole formali dell'epica con la sua fantasia lirica. La Gerusalemme conquistata, una nuova versione dell'epopea scritta per sottomettersi ai pregiudizi morali e letterari dell'epoca, fu pubblicata nel 1593, ma poeticamente fu giudicata un fallimento.
Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi (1798 –1837) è stato un filosofo, poeta, saggista e filologo italiano, considerato dalla critica letteraria come il più grande poeta italiano dell'Ottocento, nonché una delle figure più importanti della letteratura mondiale e del romanticismo letterario.

La sua costante riflessione sull'esistenza e sulla condizione umana è il tratto essenziale della sua opera, poetica e non.
Ragazzo precoce e di salute cagionevole, Leopardi nacque in una famiglia nobile, da lui descritta come insensibile. Il suo talento letterario emerse molto presto: a sedici anni aveva già imparato autonomamente il greco, il latino e diverse lingue moderne, aveva tradotto molte opere classiche e aveva scritto due tragedie, molte poesie italiane e diversi commenti accademici.
Lo studio eccessivo purtroppo danneggiò in modo permanente la sua salute: ebbe problemi di vista, alla fine diventò cieco da un occhio e sviluppò una patologia cerebrospinale che lo afflisse per tutta la vita. Costretto a sospendere gli studi per lunghi periodi, ferito e rattristato dall'indifferenza dei genitori e sostenuto solo dal fratello e dalla sorella, riversò le sue speranze e le sue amarezze nelle sue composizioni poetiche.
La sofferenza di Leopardi fu alleggerita nel 1818 dalla visita dello studioso Pietro Giordani, che lo esortò ad affrancarsi dalla dolorosa situazione familiare. Giacomo si recò a Roma, per poi tornare a casa per un altro doloroso periodo, rallegrato solo dalla pubblicazione nel 1824 della sua raccolta di versi, Canzoni. In quegli anni compose alcune delle sue poesie più celebri e amate, tra cui è impossibile non citare L’Infinito.
L'espressione più alta della poesia di Giacomo Leopardi, L'Infinito, è insieme un’opera filosofica e artistica, che armonicamente riassume le profonde meditazioni filosofiche del poeta.
Nel 1825 accettò un'offerta per editare le opere di Cicerone a Milano. Negli anni successivi viaggiò tra Bologna, Recanati, Pisa e Firenze e pubblicò Versi (1826), una raccolta di poesie, e le celebri Operette morali (1827),un'esposizione della sua dottrina filosofica.
Leopardi si trasferì a Roma, poi a Firenze, e infine si stabilì a Napoli nel 1833, dove, tra le altre opere, scrisse la Ginestra.
Negli ultimi anni di vita Leopardi abbandonò i miti e le figure illustri del passato, che giudicava come temi e simboli privi di alcun significato, dedicandosi al tema della sofferenza, che affrontò in modo sempre più "cosmico".
Tra gli ultimi componimenti non possiamo non ricordare A Silvia, dedicata alla ragazza che aveva incarnato per lui le sue speranze e illusioni del giovane poeta, e che morirà di tubercolosi.
La morte giunse anche per lui, improvvisamente, durante un'epidemia di colera a Napo
Alessandro Manzoni
Vuoi insegnare italiano online? Apprendi la storia e le opere di Manzoni!
Alessandro Manzoni (1785-1873) è stato un importantissimo poeta, romanziere e filosofo italiano, ed è universalmente noto per il suo celebre romanzo, I promessi sposi, considerato uno tra i capolavori della letteratura mondiale.

La sua opera è infatti un simbolo del Risorgimento italiano, sia per il suo messaggio patriottico, sia per il ruolo fondamentale ricoperto nello sviluppo della lingua italiana moderna. Manzoni contribuì infatti alla definizione della lingua italiana moderna e contribuì a creare una certa unità linguistica in tutta Italia.
I promessi sposi sono ambientati in Lombardia nel 1628, e la narrazione si svolge durante gli anni della dominazione spagnola e contiene una straordinaria descrizione della peste che colpì Milano intorno al 1630.
I promessi sposi
L’opera fu pubblicato in tre volumi nel 1825-26, mentre l'edizione completa fu pubblicata nel 1827. Ambientato nella Lombardia dell'inizio del XVII secolo durante il periodo della Guerra dei Trent'anni e della peste, il romanzo è il racconto appassionante e avvincente della lotta di due giovani, Lucia e Renzo, il cui desiderio di sposarsi è ostacolato da un feroce tiranno locale e dalla codardia del loro sacerdote. Un frate coraggioso, Fra Cristoforo, sostiene la causa dei due innamorati e li aiuta attraverso molte avventure verso la salvezza e il matrimonio.
Il romanzo portò a Manzoni un immediato successo ed ebbe un enorme impatto sul sentimento patriottico degli italiani del periodo risorgimentale. L’opera divenne inoltre un modello per molti scrittori italiani successivi.
Italo Svevo
Italo Svevo ( 1861- 1928), romanziere italiano e scrittore di racconti, pioniere del romanzo psicologico in Italia.

Nato a Trieste con il nome Aron Ettore Schmitz da padre ebreo tedesco e madre italiana, Svevo fu il primo di sette figli, e crebbe con la grande passione per la letteratura fin dalla giovane età, appassionandosi alle opere di Goethe, Schiller, Shakespeare e ai classici della letteratura francese e russa.
Svevo fu cittadino dell'Impero austro-ungarico fino alla fine della prima guerra mondiale. Parlava l'italiano come seconda lingua, poiché la sua lingua madre era il dialetto triestino, e imparò anche il tedesco.
Svevo cercò di concludere i suoi studi prima di essere costretto ad assumersi la responsabilità finanziaria degli affari del padre, il quale aveva una vetreria e aveva dovuto dichiarare fallimento. Iniziò dunque a lavorare come impiegato di banca presso l'Unionbank di Vienna, lavoro che servì da ispirazione per il suo primo romanzo, Una Vita (1892), utilizzando lo pseudonimo letterario con il quale diventerà celebre. Il libro sfortunatamente non ebbe alcun successo.
Anche il suo secondo romanzo, Senilità (1898), fu accolto con scarso entusiasmo. Nel 1919 iniziò a lavorare a La coscienza di Zeno, la sua opera più celebre.
La coscienza di Zeno
L'opera, che mostra l'interesse dell'autore per le teorie di Sigmund Freud, è presentata sotto forma di diario scritto da Zeno Cosini, protagonista e inaffidabile narratore, specchio dello stesso Svevo. La coscienza di Zeno non guarda mai al di fuori degli angusti confini di Trieste: l’autore usa spesso l'arguzia nelle sue osservazioni su Trieste e, in particolare, sul suo protagonista, un uomo indifferente, che tradisce la moglie e mente al suo psicanalista cercando di spiegargli il suo vissuto rivisitando i propri ricordi.
Uno dei temi centrali del romanzo è la dipendenza dalle sigarette di Zeno, argomento che attraverserà tutta l’opera e che accomuna il protagonista a Zeno stesso, che nella sua vita fu un tabagista.
Il romanzo di Svevo non ricevette all'epoca quasi nessuna attenzione da parte dei lettori e della critica italiana. L'opera sarebbe potuta scomparire del tutto, se non fosse stato per gli sforzi di James Joyce, amico dell’autore, che aiutò Zeno a far tradurre l’opera in francese e a pubblicarla a Parigi, dove i critici lo accolsero favorevolmente. Ciò spinse i critici italiani, tra cui Eugenio Montale, a scoprirlo.
Elsa Morante
Elsa Morante (1912-1985) è stata una importante romanziera, autrice di racconti e poetessa italiana.

Morante è celebre per la qualità epica delle sue opere, le quali sono solitamente incentrate sulle lotte dei giovani nel venire a patti con il mondo dell'età adulta.
La Morante mostrò molto presto il proprio talento letterario e, sebbene la sua educazione formale rimase incompleta, ebbe la possibilità di entrare in contatto con i principali scrittori italiani dell'epoca, rimanendo tuttavia in gran parte al di fuori del movimento del neorealismo all'interno del quale operarono molti di essi.
Il suo primo romanzo, Menzogna e sortilegio, racconta la complessa storia di una famiglia del sud Italia attraverso la memoria e l'immaginazione di una giovane donna. Il romanzo successivo dell’autrice, L'isola di Arturo (1957), prende in esame la crescita di un ragazzo, dai sogni dell'infanzia alle dolorose disillusioni dell'età adulta. Questo romanzo, per il quale Morante vinse il Premio Strega – fu la prima donna a riceverlo- si distingue per il suo delicato lirismo e per la sua commistione di dettagli realistici con un'atmosfera a tratti irreale.
La Storia
La sua opera successiva, il romanzo La storia (1974), al momento della pubblicazione incontrò reazioni contrastanti, ma ottenne un grande successo commerciale. Oggi l’opera è considerata un capolavoro della letteratura europea.
Ambientato principalmente a Roma tra il 1941 e il 1947, il fulcro della narrazione ruota intorno all'ardua esistenza di una semplice maestra elementare di origine ebraica e del suo giovane figlio, Useppe, nato da un rapporto sessuale imposto con la violenza da un soldato tedesco.
Il romanzo afferma la visione dell'autrice, che si tinge di anarchismo negando ogni possibilità di efficacia alla politica umana e, con la morte di Useppe, sembra escludere ogni ultima speranza di umanità.
L'ultimo romanzo di Morante, Aracoeli (1982)), racconta un viaggio intrapreso dal suo travagliato protagonista in Spagna, dove tenta di riconquistare la sua infanzia perduta e scoprire il passato di sua madre. Come la Storia, Aracoeli non è stato universalmente acclamato dalla critica, ma funge da summa di molte tematiche dell'opera di Morante.
Riassumi con IA
















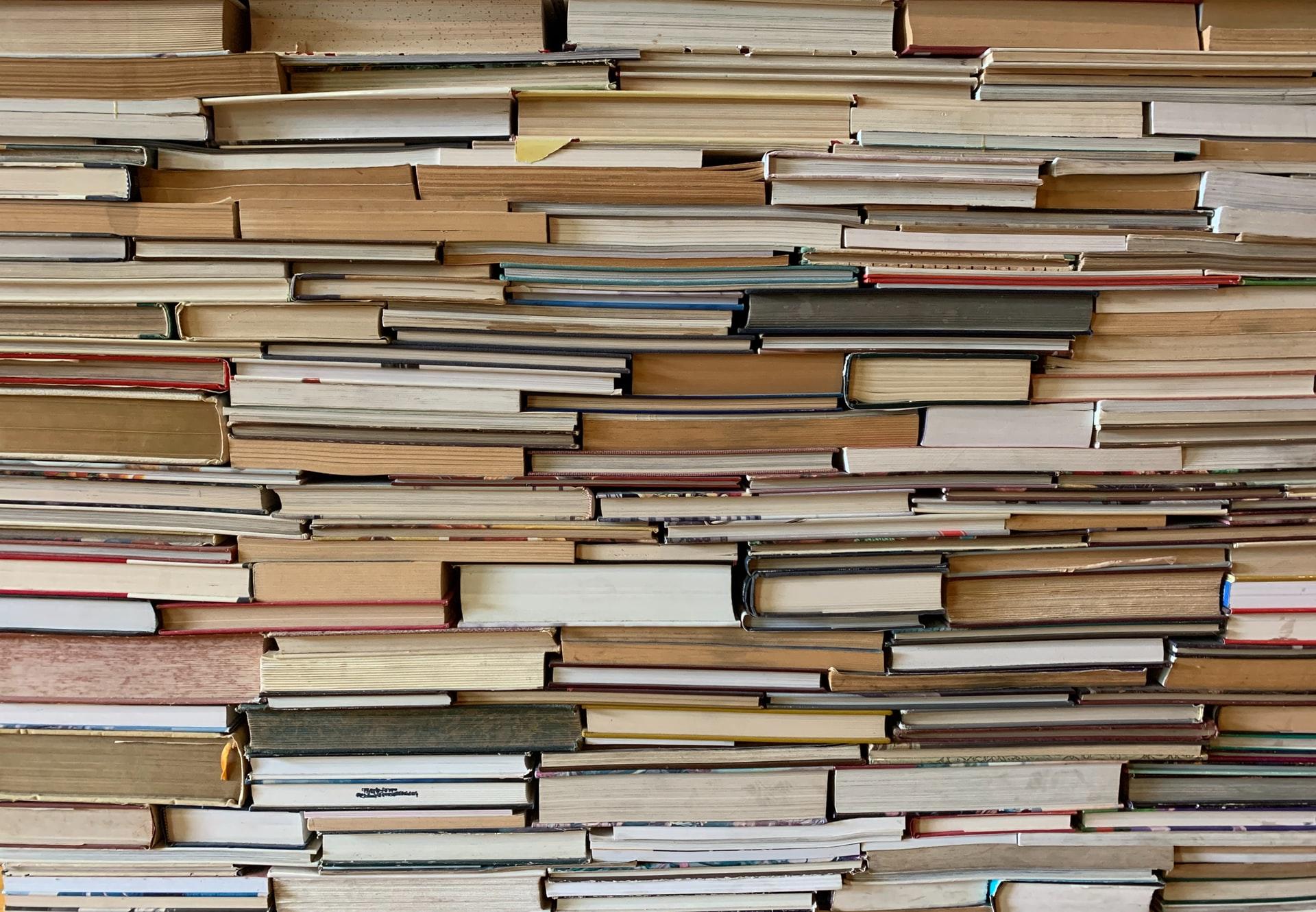








Sintetico ed essenziale,complimenti ai professori.
Grazie, siamo molto felici che l’articolo sia stato di tuo gradimento!